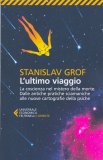Una pratica di
autocontrollo
“Sedersi” è, infatti, tra
le altre cose, una pratica di autocontrollo.
Mentre si medita non ci si
alza né ci si muove, non si fanno soldi né si passano esami, e neppure si può
essere rassicurati da una certa telefonata. Si potrebbe obiettare che anche il
servizio militare, una lezione di violino o la formazione medica permettono di
esercitare l’autocontrollo. Ma l’azione di “sedersi” fa esercitare
l’autocontrollo nei confronti di valori specifici. Qui l’azione è completamente
sostituita dall’osservazione. Certo, non varrebbe la pena di dedicare la
propria vita a questa pratica, se poi si passasse il tempo in sogni erotici o
nella preoccupazione di avere successo e riconoscimenti. Purtroppo, sogni e
preoccupazioni si presenteranno comunque, fanno parte della nostra umanità. Le varie
culture non avrebbero prodotto gli onnipresenti codici morali, i dieci
comandamenti, se non traboccassimo di centomila impulsi incontrollati.
Ma le esortazioni morali e
le prediche mi sono sempre apparse rimedi insufficienti, tutt’al più mi danno
la misura dei miei istinti più striscianti e incontrollabili. Mi servono lenti
indistruttibili, o sempre rinnovabili, attraverso le quali poter scorgere
l’amore al di là delle mie voglie e la fede al di là delle mie inquietudini.
Come distinguere ciò che in me, è convinzione radicata, ciò che forma il nucleo
della mia identità, da semplici velleità destinate a cadere? Quali sono i
personaggi che continuano a passare davanti allo specchio della mia anima
giorno dopo giorno, anno dopo anno e quali invece i buffoni che occupano il
palco per la durata di una scena?
Dal Fedone di Platone, con le parole di Socrate: “dolore e piacere non vogliono mai stare insieme ambedue nell’uomo; ma,
se qualcuno insegue o prende uno dei due, è pressoché costretto a prendere
sempre anche l’altro, quasi che essi, pur essendo due, pendessero da un unico
capo”.
L’amore una “rotta
migratoria”
Per quel che mi è dato di
capire, l’amore non è un’emozione, ma è l’organizzarsi delle emozioni. Non è
una stanza, ma il luogo in cui ci si sente a casa; non è un uccello, ma una
rotta migratoria. È un complesso di sentimenti, che va al di là dei sentimenti.
È il contrario del colpo di fulmine e della sessualità romantica. “Sedermi” mi
ha aiutato a trovare l’amore, a vivere d’amore, o quantomeno a viverne di più.
Ha ravvivato, entro i limiti delle mie possibilità e del mio carattere, il
marito, il padre, lo psichiatra, il cittadini che c’è in me. La meditazione mi
ha permesso di scrutare impietosamente e di superare certi miei atteggiamenti
sentimentali e i miei giudizi morali. Mi ha fornito uno strumento, un’attività,
una pratica con cui esprimere l’amore. Essa mi fa da leva, e nel medesimo tempo
mi stabilizza.
Come afferma Erik Erikson:
“È soltanto l’ambivalenza che rende
l’amore significativo, o addirittura possibile”.
In altre parole, è soltanto
perché siamo sia separati sia uniti, che esiste l’amore. Senza un’esistenza
individuale e degli impulsi personali, il mondo sarebbe soltanto un globo
omogeneo, spoglio di emozioni, inconsapevole.
Tuttavia, se fossimo
irrimediabilmente separati, saremmo come fredde stelle autonome poste l’una
accanto all’altra nello spazio morto.
Far coesistere gli opposti
Per me, l’amore significa
l’organizzazione delle emozioni umani in quello stato complesso in cui
separazione e fusione, individualità e coinvolgimento, io e mancanza di un io,l
paradossalmente coesistono. Solo un individuo può amare, ma per farlo deve
cessare d’esser tale.
“Sedermi” mi ha aiutato a
svilupparmi in entrambe le direzioni. Quando mi rinchiudo, mi costringe a
spalancarmi, e quando mi stacco, come una scheggia che salta via, mi
ricongiunge al corpo a cui appartengo.
“Sedermi” potenzia lo
sforzo che faccio nei miei confronti, mette in moto la mia volontà e il mio
impegno. Nello stesso tempo demolisce le tattiche che adotto per proteggermi
per difendermi, sconvolgendo il concetto che ho di me stesso. Costruisce e
nello stesso tempo smonta questo “me”, pezzo per pezzo.
In me dilagano tutte le
speranze, tutte le aspirazioni, tutte le paure.
Stringere la mano alla
morte
Meditare significa morire a
ciò che accade intorno a me, abbandonare la distrazione, far cessare ogni
desiderio di gratificazione. È la vita di questo momento, così com’è. Questa
rigorosa messa fuoco mi riuscirà molto, molto utile un giorno. Ma lo è fin
d’ora.
Nel cuore della storia
La vita ha inizio in una
selva di condizionamenti: le nostre reazioni istintive a questi
condizionamenti creano altrettante limitazioni. Per liberarci, occorre che
diventiamo consapevoli del processi di condizionamento, e impariamo a dargli
una risposta adeguata. La meditazione mi rende cosciente d’ogni scelta, perciò
quando passo all’azione, mi ritrovo più attento, più concentrato, più cosciente
e comprensivo.
La
meditazione Vipassana
Vipassana è il nome della
meditazione che punta alla diretta purificazione mentale e conduce alla pace
profonda. Il termine “vipassana”, che in un’antica lingua dell’India, il pali,
la lingua in cui c’è stato tramandato l’insegnamento del Buddha, significa
“visione profonda”, indica la tecnica meditativa praticata e insegnata dal
Buddha stesso. Vipassana non è buddismo, la religione che si cristallizzò
intorno all’insegnamento del Buddha dopo la sua morte, ma è una psicologia del profondo,
una trasmissione sistematica di verità oggettivamente verificabili.
Il nibbāna è imperturbabile pace interiore, purezza assoluta che si
può soltanto definire per mezzo di quanto essa non è: non desiderio, non-paura,
non-collera.
Le radici etimologiche del
termine nibbāna sono
indifferentemente interpretate come “nessuna freccia”, a significare che non si
può raggiungere traguardo più alto nella vita, oppure come “nessun vento” per
indicare che si è al di là d’agitazione e cambiamento.
Il nibbāna è contrassegnato dall’assenza di fattori contaminanti quali
i desideri, le preoccupazioni, l’intolleranza. Esso nasce dall’estinzione della
bramosia e dall’avversione, dalla serenità connessa alla visione impersonale; è
pace senza fine, realizzata nell’attimo del presente.
Una
concentrazione diversa
… la calma della
concentrazione sul nudo respiro prescinde da qualsiasi situazione; non contiene
“se” o “quando”, è priva di immagini. È come una pozza di luce, o un chiaro di
luna; per la durata di un attimo, solo la lieve increspatura del respiro inonda
la mente. Incredibilmente, la pace appare possibile. Frutto dell’osservazione,
tuttavia non è osservabile, come l’aria fresca. Emerge da uno sforzo, da una
partita giocata con se stessi, poi fluisce senza scosse, diventa senso di
libertà incontenibile. Solo dopo che è nuovamente svanita, e si è riassorbiti
dall’attività mentale, se ne sente la mancanza.
La
meditazione vera e propria
Lo studente “inizi a
osservare il continuo sorgere e svanire dei fenomeni all’interno del suo corpo
… questa consapevolezza si svilupperà fino al punto in cui rimarrà solo la pura
comprensione e la pura attenzione, ed egli si ritroverà perfettamente equanime,
senza più alcun attaccamento per tutto ciò che esiste nel mondo della mente e
della materia”. Con questa frase, il Buddha descrive la vipassana.
Partendo dalla
concentrazione sul respiro e sul contatto del respiro con il corpo, lo studente
si esercita a osservare, prima singolarmente e poi simultaneamente, le varie
parti del suo corpo, fino ad acquistare la capacità di essere consapevole di
tutte le sensazioni che si manifestano nel cranio, sulla fronte, negli occhi,
nelle narici, nella bocca, nel petto, nel cuore, nei polmoni, nell’addome …
La meditazione diventa il
fluire della consapevolezza attraverso l’intera struttura fisica,
l’esplorazione attenta di un territorio rappresentato dal soggetto stesso. È
come se la massa del corpo si frantumasse nelle infinite particelle che la
compongono.
Ma perché concentrarsi sul
corpo?
Noi ci identifichiamo in
primo luogo con i nostri pensieri, i nostri sentimenti, la nostra psiche. Una
tecnica che continuamente ci richiede di spostare la concentrazione dalla mente
al corpo, può veramente andare in profondità, può essere qualcosa di diverso da
una ginnastica tranquillizzante? Questa
meditazione sul respiro e sulle sensazioni del corpo, quale relazione ha con la
purificazione mentale e la pace interiore?
Per penetrare nelle
profondità della mente, dobbiamo imparare a osservarla là dove essa entra in
contatto con il corpo. L’osservazione di noi stessi non può limitarsi alla sola
mente, perché noi siamo continuamente sopraffatti dalla mente. La nostra obiettività,
la nostra capacità di osservazione, cono viziate dal bisogno mentale di
tradurre in immagini, di sceneggiare tutto. La mente, registra instancabile,
non fa altro che sfornare film. E noi
siamo quei film, o almeno così pensiamo. Noi crediamo in ciò che la mente
proietta sul nostro schermo, ne siamo catturati, viviamo come se tutto ciò
fosse vero.
Ma quel palcoscenico che ci
vede sempre protagonisti, lo schermo che noi occupiamo quasi totalmente, si
regge tutto su quel pacchettino di materia che è il nostro corpo.
Esistono diversi livelli di
realtà. L’impegno che mettiamo nelle cose di questo mondo complesso, dove
abilità, lavoro e pragmatismo ci procurano cibo, riparo, istruzione e affetto.
Ma in ultima analisi, l’universo visibile e tangibile è un flusso mutevole di
materia, che continuamente forma nuove aggregazioni. Il fatto definitivo è il cambiamento. La meditazione profonda,
finalizzata a una pace duratura, deve necessariamente scavare più a fondo,
oltre l’attività mentale funzionale, ma effimera, di una realtà transitoria,
fino a toccare le verità esterne, che rappresentano il fondamento stabile di
ogni personalità.
La vipassana è una base di
osservazione sottomarina del mutamento. Con essa, l’osservazione neutrale e
spassionata penetra fino alle radici del senso di noi stessi. Ogni pensiero,
ogni fantasia, ogni immagine mentale è un prodotto del corpo che li contiene.
Ogni guizzo della mente è contrassegnato da una reazione chimica. Potremmo dire
che la mente è il succo che spremiamo dal cambiamento. I neurotrasmettitori,
sostanze biochimiche complesse che fluiscono attraverso le sinapsi delle
microforeste dendridiche del cervello, influenzano il nostro umore e le nostre
attività mentali.
Gli psichiatri prescrivono
queste sostanze biochimiche per curare la depressione, per calmare l’ansia o
per liberare dall’orrore schizofrenico.
L’”io sono” che abita i
nostri pensieri e le nostre emozioni è un prodotto delle possibilità della
biologia, della chimica e della fisica del nostro corpo. Quando pensiamo, ne
modifichiamo la struttura chimica. E schemi persistenti di pensiero modificano
il nostro corpo, provocano l’ulcerazione del duodeno, spezzano il cuore o ci
ridanno vitalità. Mente e corpo sono le due facce di un’unica medaglia.
La mente e le sue illusioni
Ma è la mente, considerata
da sola, che genera l’illusione dell’”io sono”; essa nasconde la realtà del
cambiamento inarrestabile che avviene in ogni atomo, ogni corpo, ogni galassia.
La mente che non è in contatto con il proprio corpo sogna di essere libera da
questo flusso inesorabile. Essa, sradicata dalla verità dell’incessante
trasformazione, elabora le illusioni, che le impediscono di integrarsi
armoniosamente con la realtà del mondo.
Come può una mente,
soggetta a una continua auto-ipnosi, acquisire una visione più ampia e più
stabile?
La mente umana può soltanto
sperimentare la verità quando quella verità è direttamente percepita dalla
struttura fisica dell’io. Per collocarci all’esterno di noi stessi e poterci
vedere come siamo, per scrutare la nostra vita con “penetrante visione
cosmica”, dobbiamo entrare in noi stessi e scoprire il moto vertiginoso delle
galassie all’interno delle nostra ossa.
Per acquistare la purezza,
oltrepassando l’illusione e la frammentazione della personalità, occorre
sperimentare il continuo cambiamento di questo nostro io immaginario.
E la prima goccia di
purezza filtra nella mente quando percepiamo il dissolversi del corpo nel
flusso impersonale dell’universo materiale.
Il paradosso della
vipassana
Quando il meditante impara
a rimanere seduto in tranquillità, osservando semplicemente il sorgere e il
passare delle sensazioni del proprio corpo, senza minimamente reagire, ritorna
il flusso di pensieri che l’avevano assediato quando si concentrava sul respiro;
a questi si aggiungono reazioni di oppressione e di sollievo fisico assenti in
precedenza. A volte la vipassana gli apparirà un vero paradosso: spinto lì alla
ricerca della pace, si troverà, almeno temporaneamente, più che mai nell’occhio
del ciclone. A rari istanti di chiarezza stellare succede il solito frastuono
mentale.
La pace di una mente
purificata
Il principiante ora può
accorgersi di come i pensieri scaturiscano dal suo corpo e, a loro volta,
trasformino le sue sensazioni fisiche. È un inizio di libertà dalle coercizioni
della vita animale: entrano in funzione nuovi organi mentali, nuovi muscoli
spirituali. Diventa possibile osservare i mutamenti di corpo e mente, come si
osservano le stagioni della terra e i periodi storici nella geografia del
tempo.
Man mano che si dirada
l’ignoranza che ci aveva così a lungo accecati, viene in luce la saggezza di
una mente purificata. Perché continuare ad alimentare e legittimare tutto
quell’odio e quella paura, visto che il copione è del tutto provvisorio?
L’insistente ricerca di una felicità permanente entro i confini di questa vita
ci appare qualcosa di infantile, un sognare ad occhi aperti. Niente più
“vissero per sempre felici e contenti”, dunque, perché lì, nell’attaccamento
alla fiaba della nostra infanzia, è la sorgente della nostra sofferenza.
Il sorgere spontaneo della
compassione
Ci si rende conto che ogni
essere vivente patisce la nostra stessa angoscia, e ci si sente chiamati ad
aiutare gli altri a liberarsi almeno di quel tanto di cui siamo riusciti a
liberarci noi.
Consapevolezza ed
equanimità, strumenti di purezza
Una mente equilibrata, che
non vuole nulla, è obiettiva, realistica, pulita. Sono le nostre aspettative
auto-referenziali, le nostre proiezioni, la nostra agitazione a renderci
confusi. Purezza vuol dire consapevolezza ed equanimità.
Il sentiero che conduce al nibbāna è semplicemente pace che porta a
una pace sempre più profonda e che non si può scalfire.
Il meditante ha capito che
la sofferenza è frutto del gioco ossessivo delle emozioni; adesso, per semplici
istanti, ore, giorni, ha sperimentato la libertà.
In modo intermittente o per
intere giornate si è sentito vivo e rigoglioso; consapevole, ma privo di
reazioni verso il piacere e il dolore, continuamente pronto a mettersi in
disparte per osservare spassionatamente, senza ombra di desiderio o avversione.
Tempo e cambiamento
Quella dell’immobilità
fisica è una paura primordiale (tutti abbiamo sognato di essere paralizzati,
incapaci di correre e di parlare), e la vipassana ci prepara ad affrontare
questa paura. Il timore del dolore fisico è centrale nell’esperienza umana: la
vipassana ci conduce in esso, e ci riporta fuori. Anche quella della solitudine
è una paura profondamente radicata. Pur aiutandoci a sviluppare fiducia, senso
d’appartenenza, fede, la pratica della vipassana è contrassegnata dalla più
profonda solitudine nel silenzio; allora impariamo a usare quel gelo per
calmare i bollori della nostra mente eccitata.
Una delle ragioni per cui
la mente è sempre in fuga, preda della fantasia, di progetti e di ricordi, è
che il concentrarsi sulla realtà fisica immediata inevitabilmente illuminerà la
temuta verità: che il corpo va in rovina, ora, in questo momento, in ogni
momento, irreversibilmente. Uno dei paradossi della tecnica vipassana è che la
profonda concentrazione e il rilassamento fisico, la stupenda pace luminosa,
conducono alla radice di quella paura … facendocela scoprire come una verità
semplice e innocente, come il fatto che alla notte succede il giorno, alla fame
la sazietà, alla stanchezza il sonno, al risposo notturno le stelle del
mattino. Una mente, che osserva costantemente il corpo, conosce sia i limiti di
quel corpo sia la vibrante energia universale che fluisce da forma a forma.
L’origine
della sofferenza
La sofferenza deriva dall’ignoranza
della nostra vera natura. La comprensione profonda della verità, l’esperienza
della verità, ci libera dalla sofferenza. Allora diventa semplice prendere il
sentiero giusto nella vita, quello che porta a trovare l’origine della
sofferenza e il metodo per eliminarla, condizione “questa” indispensabile alla
guarigione di sé e degli altri.
Con la vipassana possiamo
renderci conto che siamo noi a creare la realtà in cui viviamo, e che il solo
modo di uscire dalla sofferenza è dentro di noi. Ciò che l’individuo chiama “sé”,
è una struttura psicofisica, un flusso impersonale di eventi magici, ognuno dei
quali trae origine da quello precedente. Come ogni altro fenomeno naturale,
siamo formati da una massa di particelle, un fascio d’energie regolato dalle
leggi scientifiche che governano l’universo. Queste leggi non operano solo su
elettroni, protoni e neutroni, ma anche su pensieri e sentimenti, giudizi e
sensazioni. Al livello più profondo, mente e corpo si uniscono al punto in cui
il continuo sorgere e svanire della materia all’interno del nostro corpo entra
in contatto con la mente. Gli avvenimenti e i pensieri che si scontrano con i
nostri sensi producono dei cambiamenti nelle nostre sensazioni fisiche. La valutazione
di questo sostrato sensoriale somatico e la nostra reazione ad esso formano i
complessi psicofisici con cui ci identifichiamo. L’ininterrotta reazione
mentale al dolore e al piacere fisico condiziona la definizione inconscia di
chi e di che cosa siamo.
La meditazione vipassana ci
permette di sperimentare le vibrazioni profonde che sottostanno alla nostra
mente inconscia. Essa reagisce con desiderio o avversione nei confronti di ciò
che avviene nel nostro corpo, e fa affiorare queste reazioni nella parte
cosciente della mente. Attraverso questo processo, il meditante può trasformare
le autoidentificazioni somatiche primitive, che avrebbero potuto provocare
sofferenza, in consapevolezza e capacità di libera scelta.
Le due qualità della
vipassana
La vipassana sviluppa in
noi due importanti qualità: la consapevolezza dell’origine del senso dell’io,
che risiede nelle sensazioni corporee, e l’equanimità. Quest’ultima è la
capacità di osservare un’infinità di
sensazioni sottili e i loro equivalenti mentali, senza formulare giudizi o
innescare reazioni, perché ci si rende conto che si tratta di fenomeni effimeri,
transitori, che non sono il sé. Questo permette un progressivo distacco dalla
precedente identificazione, inconscia e oppressiva, con il piacere e il dolore
fisico. Il sentiero della vipassana trascende il principio del piacere.
Le psicoterapia occidentali
moderne si basano sulla valutazione, sull’analisi e sull’eliminazione di
complessi. Alcuni dei loro metodi e obiettivi sono molto simili a quelli della
vipassana. Entrambe le tecniche prescrivono, come via di guarigione, la
consapevolezza sistematica, la conoscenza di sé e la libertà dai
condizionamenti passati.
Nel migliore dei casi, gli
avvenimenti dipendono solo parzialmente da me; ma le mie reazioni si
manifestano all’interno della mia vita fisica e della mia identificazione con
me stesso: finiscono dunque per essere sotto il mio controllo. Io non soffro in
conseguenza di quanto mi è accaduto, ma perché sono stato incapace di staccarmi
dalle reazioni a quegli eventi che si sono prodotte all’interno della mia mente
e del mio corpo.
La vipassana ci rende
responsabili perché, attraverso l’introspezione, ci rivela che noi diventiamo
le nostre reazioni, diventiamo ciò a cui attribuiamo valore. Il sentiero
consiste nel fare di ogni pensiero, in ogni momento, un seme d’equanimità che
darà frutti d’amore e di pace.
Gli psicologi riconosceranno
in questo aspetto della pratica il fondamento dell’assunzione di responsabilità
nella formazione del sintomo e nel capovolgimento del sintomo. Questo implicherà
una visione universale, naturale e scientifica al tempo stesso, libera da
dogmatismi e autoritarismi.
La vipassana è libera da
guro, costumi esotici, elementi rituali etnocentrici. Invece di favorire una
dipendenza cieca dal maestro, la vipassana suscita rispetto e gratitudine per
la tecnica.
Le pareti del nostro mondo
sono costruite dal nostro modo di pensare, di agire, di dare.
La vipassana è un’antichissima
psicologia di sviluppo spirituale ed è gratuita, non professionale, non
settaria, etica e universale. Si basa sull’osservazione obiettiva, metodica e
continua delle sensazioni che si manifestano nel nostro corpo. Questa particolare
forma di osservazione provoca uno sviluppo sistematico, a tutti i livelli, di
ogni strato della nostra personalità. In parte, il contributo unico che la
vipassana fornisce alla salute mentale deriva dalla sua “costellazione di
azioni psicologiche. Si può affermare che la vipassana è la creazione,
attraverso la meditazione, di un capo energetico che attiva nuovi modelli in
sei livelli della personalità.
- Provoca mutamenti a livello molecolare nel corpo del meditante. La sistematica auto-osservazione non reattiva sempre più fine e penetrante altera il flusso delle sostanze chimiche correlate con lo stress.
- Cambia la biologia del corpo del meditante. Mutano gli schemi di reazione e la composizione neurochimica, e lo stile di vita è sempre più improntato alla consapevolezza e alla compassione, ne sono influenzati il sonno, la dieta e i modi in cui si manifestano il dolore e il piacere.
- Ha un effetto straordinario a livello psicologico. Si eliminano vecchi complessi, si coltivano nuovi atteggiamenti e qualità, riemergono i ricordi, i rapporti sono visti e sviluppati in una luce nuova, si scompongono le prospettive future e le si impostano in un’altra maniera.
- Educa ai valori morali.
- È una psicologia ambientale che promuove l’armonia. La maggior parte di ciò che ci capita dipende dal modo in cui trattiamo il mondo.
- È la via che porta al nibbāna, alla trascendenza del mondo materiale.
L’impermanenza
dell’impermanenza
Aniccā (lingua pali, usata ai tempi del Buddha)
= l’impermanenza, il cambiamento. È un segnale un indicatore di direzione, come
i tumuli di pietre che il pellegrino incontra sui sentieri dell’Himalaya, che
sembrano abbracciare le nuvole, segnali che mostrano la via tracciata da altri
pellegrini.
Fonte: Karma e Caos